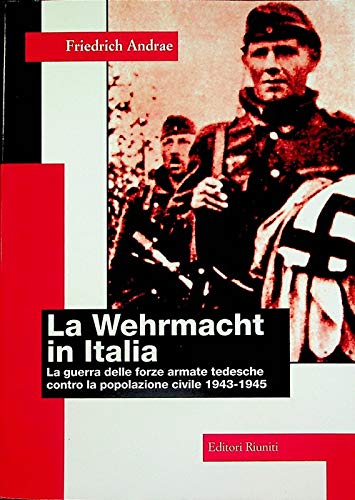“Kampfanweisung für die Bandenbekämpfung im Osten” (direttiva di combattimento per la lotta alle bande nell’est), emanata nel 11 novembre del 1942, e l’ordine del Führer Bandenbekämpfung (lotta alle bande), emanato il 16 dicembre dello stesso anno e che integrava direttamente la Kampfanweisung, diventarono vincolanti anche in territorio italiano dopo l’8 settembre 1943 e costituivano le norme di riferimenti contro i “banditi” e i loro “simpatizzanti” per i soldati tedeschi impegnati nell’occupazione dell’Italia <252.
Per “simpatizzanti” i tedeschi consideravano tutti gli italiani, bambini compresi, che in forma diretta o indiretta, sostenevano i combattenti della Resistenza. La Kampfanweisung, più comunemente nota come Merkblatt 69/1, in tal senso contemplava espressamente l’adozione di un comportamento da parte dei soldati tedeschi nei confronti dei civili di estrema crudeltà, considerando la mancanza di insensibilità nell’esercizio della violenza un atto di irresponsabilità <253.
La severità delle misure adottate e la severità delle pene inflitte ai collaborazionisti dei partigiani avrebbero dovuto dissuadere la popolazione civile dal favorire o appoggiare le bande partigiane, privando così la Resistenza armata dell’humus in cui svilupparsi e rafforzarsi. Quelle direttive di combattimento contemplavano l’uccisione di civili, anche di donne, ragazze, bambini; e ogni comandante di reparto era direttamente responsabile del fatto che quei soggetti civili venissero fucilati, o meglio impiccati, quando venivano catturati durante le azioni di combattimento. L’ordine di Hitler, che definiva i partigiani una peste, nelle disposizioni sulla guerra ai partigiani all’Est e nei Balcani,
prescriveva che “la truppa è perciò autorizzata e tenuta nell’ambito di questa lotta a utilizzare senza limitazioni, anche nei confronti di donne e bambini, qualsiasi mezzo, se questa è l’unica via che conduce al successo” <254. Quindi, come regola di condotta militare verso i civili, veniva incentivata la più intransigente efferatezza, stimolata dall’assoluta garanzia di impunità delle truppe. Infatti, Hitler impose il fermo divieto di chiamare a rispondere, con sanzioni disciplinari o di fronte al tribunale di guerra, qualsiasi tedesco impegnato nella lotta contro le bande a causa del suo comportamento verso i partigiani o i suoi simpatizzanti, annunciando così ai suoi sottoposti che avevano carta bianca a ogni forma di crimine compiuto nella lotta alle bande. Come ha fatto notare Klinkhammer la Merkblatt 69/1 e l’ordine Bandenbekämpfung, non erano “né una disposizione permanente, né uno schema (…) come nessun altro tipo di combattimento la lotta contro le bande richiede duttilità e capacità di adattamento alle singole situazioni” <255. Ciò significava che le direttive non ordinavano una determinata procedura in modo perentorio, bensì legittimavano esplicitamente una procedura spietata, senza tuttavia richiederla in modo vincolante a tutti i membri della Wehrmacht, che comunque potevano richiamarsi a quella disposizione per giustificare a posteriori un eccidio.
Nello scenario di guerra italiano, fin dai primi giorni dell’occupazione tedesca la guerra ai civili dunque assunse quei caratteri di brutalità contenuti nella Merkblatt 69/1. L’utilizzo radicale della licenza al massacro in Italia, garantito dalla direttiva, sottolineava il disprezzo totale verso i partigiani nutrito dalla gerarchia militare tedesca. Fu soprattutto Kesserling che, in qualità di comandante in capo della Wehrmacht in Italia, si distinse per la personale brutalità e crudeltà profusa nella lotta contro le bande. In particolar modo per Kesserling l’applicazione delle direttive divenne centrale nella primavera del 1944. Quando l’azione partigiana si faceva sempre più intensa e alcuni episodi, come l’attentato in via Rasella, convinsero il comando generale della Wehrmacht che non sempre la repressione perpetrata con i mezzi più disumani portava al raggiungimento dell’obiettivo di eliminare i partigiani e i loro collaboratori, ma poteva creare una maggiore coesione fra la popolazione e la Resistenza.
Il foglio di istruzioni Merkblatt 69/2 Bandenbekämpfung, entrato in vigore per le forze armate tedesche il 1° aprile del 1944, teneva ufficialmente conto delle preoccupazioni dei tedeschi di impedire che la popolazione dei paesi occupati collaborasse con i partigiani e rappresentava un cambiamento della strategia generale della lotta partigiana. Il provvedimento si differenziava molto dalla Merkblatt 69/1 in merito al trattamento da riservare alla popolazione. Vi si affermava infatti che azioni collettive contro la popolazione di interi paesi poteva essere ordinata soltanto in casi eccezionali ed esclusivamente dai comandanti di divisione o da comandanti equiparati delle SS e della polizia; che le truppe dovevano considerare prigionieri di guerra tutti quei partigiani che durante i combattimenti si arrendevano o venivano catturati indossando l’uniforme nemica o gli abiti civili, viceversa chi indossava l’uniforme tedesca o quella di un esercito alleato doveva, dopo un accurato interrogatorio, essere fucilato; mentre nulla cambiava per chi combatteva nella Resistenza <256.
Però, in risposta al cambio di strategia voluto dal Comando supremo della Wehrmacht, Kesserling e i suoi comandanti d’arma chiedevano un comportamento più brutale alle truppe tedesche di stanza in Italia. Il feldmaresciallo diramò una serie di ordini volti, nella ripetitività dei contenuti della direttiva Merkblatt 69/1, a indottrinare le unità subordinate al suo comando al mantenimento delle vecchie direttive <257. La serie di disposizioni emanate da Kesserling nella primavera-estate del 1944 comportavano un coinvolgimento sempre più pronunciato della popolazione civile nella repressione partigiana. Kesserling si attendeva dai propri ufficiali azioni rapide e risolute, in caso di aggressione dovevano aprire il fuoco senza particolare riguardo per gli eventuali passanti, e i comandanti deboli ed indecisi, la cui condotta lassista minacciava la sicurezza delle truppe affidategli e il prestigio della Wehrmacht, dovevano essere sottoposti ad un inflessibile giudizio <258.
Conseguenza di quella svolta fu anche la libertà concessa ai comandi dei singoli reparti nella scelta dei mezzi repressivi e nella misura della loro durezza. L’impunità accordata per la condotta inflessibile della repressione fu confermata da Kesserling nell’ordine del 17 giugno 1944, nel quale prescriveva: “La lotta contro le bande deve essere condotta perciò con tutti i mezzi a disposizione e con la massima asprezza. Io coprirò ogni comandante che nella scelta ed asprezza del mezzo vada oltre la misura a noi di solito riservata” <259, dimostrando così una indiscutibile applicazione degli ordini di Hitler e una linea di continuità con le direttive della lotta alle bande emanate nel 1942. Le truppe tedesche dovevano eliminare durante i combattimenti i partigiani, anche quando questi venivano fatti prigionieri. Quindi, contrariamente a quanto disponeva il foglio di istruzioni Merkblatt 69/2, i partigiani catturati non erano considerati prigionieri di guerra. Tale condotta voluta da Kesserling significava in sostanza istigazione alle stragi, richiesta alle truppe tedesche in concomitanza alla fase di massima espansione dell’attività partigiana, compresa tra i mesi di giugno e ottobre del 1944, periodo in cui i tedeschi dovettero registrare la massima diffusione della renitenza ai bandi della Rsi e dell’avanzata alleata in Italia.
Lo stile di comando, condotto con risolutezza da Kesserling, riguardava tutta l’Italia occupata. Dalla fine di aprile del 1944 il comando supremo della Wehrmacht risolse a suo favore un conflitto di interessi sorto con le SS di Himmler, assumendo la guida suprema di tutta la lotta alle bande sul territorio italiano. Infatti, anche se al di fuori della zona di operazioni dell’esercito e della fascia costiera profonda 30 chilometri, la responsabilità operativa di tale lotta spettava al comandante supremo delle SS e della polizia Wolff, egli era però personalmente sottoposto al comandante superiore sud-ovest e doveva agire in base alle sue direttive <260. Kesserling aveva quindi raggiunto un obiettivo che perseguiva da tempo, e le rappresaglie contro il popolo italiano calcolate come strumento di lotta indiretta ai partigiani erano indicative di come egli intendesse procedere. In particolare appariva pericoloso ai tedeschi il fatto che in alcune parti delle Alpi occidentali i partigiani controllassero le retrostanti vie di comunicazione impedendo non soltanto i rifornimenti ma rappresentando una costante minaccia durante i ripiegamenti dell’esercito tedesco. Erano soprattutto gli attentati con cui venivano fatti saltare i ponti quelli più efficaci per bloccare le vie di comunicazione. Perciò furono messi in atto rastrellamenti volti a colpire quelle zone in cui si erano moltiplicate le notizie circa le azioni di sabotaggio <261. Durante i rastrellamenti le rappresaglie erano ormai diventate un fenomeno diffuso, un vero e proprio strumento di lotta, e tendevano a non colpire solo più i partigiani veri o presunti ma anche l’intera popolazione di una determinata area, considerata in blocco come sospetta di connivenza.
L’efferatezza degli ordini repressivi contro la popolazione civile, emanati dalle gerarchie militari tedesche, quindi era finalizzata ad istigare nella popolazione l’odio verso i partigiani. Ma nella determinata applicazione di quelle direttive militari non costituivano un elemento secondario gli aspetti di ordine militare, etnico e razziale concernenti l’immagine che i tedeschi avevano degli italiani. Infatti secondo Hitler una delle cause che determinarono la caduta della Germania era attribuibile alla debolezza del partner dell’Asse. Agli italiani Hitler addossava la colpa di aver perso la “campagna d’Oriente”, circostanza che aveva influenzato negativamente l’esito della guerra tedesca. Per il Führer, a causa delle difficoltà militari italiane patite in Grecia, la Wehrmacht era dovuta intervenire nell’Europa sudorientale, provocando così un fatale ritardo dell’avanzata tedesca contro l’Unione Sovietica che, nel proseguo della guerra, si rivelò essere, secondo le riflessione del Führer sulle cause della sconfitta della Germania nella seconda guerra mondiale, l’inizio della fine. Anche se la realtà storica ha sottolineato che non fu possibile osservare le scadenze prefissate per l’inizio dell’operazione Barbarossa per una serie di contrattempi di carattere logistico e legati alle cattive condizioni del tempo, e il ritardo imputabile alla guerra lampo contro la Jugoslavia e la Grecia intrapresa dai tedeschi venuti in soccorso agli italiani era quantificabile in due settimane (un tempo breve da rimanere insignificante ai fini del fallimento dell’operazione Barbarossa), restava comunque il fatto che le false accuse italofobe trovarono corrispondenza in una serie di pregiudizi radicati nei tedeschi che addossarono agli italiani il ruolo di capro espiatorio declassandoli come appartenenti ad una razza inferiore.
Come ha fatto notare Schreiber, la caduta in discredito degli italiani non era una semplice reazione d’impulso all’8 settembre, ma ebbe al contrario un lungo periodo di gestazione fondato su sedimenti ideologici presenti nelle storie nazionali di entrambi i paesi. I risentimenti contro gli italiani risalivano soprattutto alla prima guerra mondiale, quando l’Italia entrò nel conflitto mondiale – la guerra era già iniziata da dieci mesi – schierandosi a fianco dell’Intesa contro l’Impero austro-ungarico fin allora suo alleato; ma si poteva ripercorrere a ritroso la secolare storia dei Savoia per verificare l’inaffidabilità dal punto di vista della politica delle alleanze della casa regnante che non aveva “mai concluso una guerra dalla stessa parte in cui l’aveva iniziata tranne in casi in cui aveva cambiato due volte fronte” <262. Antichi risentimenti resi ancora più accesi dalla condotta negativa del conflitto e dal suo esito da parte dell’Italia. L’8 settembre si inserisce nell’immagine che i soldati tedeschi avevano o erano indotti ad avere degli italiani come ulteriore e definitiva abiezione che il popolo tedesco era disposto ad accettare. Il feldmaresciallo Kesserling dichiarò di provare nei confronti degli italiani soltanto odio, e contemporaneamente sottolineava con forza che verso i traditori, macchiatisi del più meschino dei tradimenti, non vi poteva essere nessuna indulgenza. Una esternazione quella di Kesserling che suonava come una convinta adesione alla volontà espressa da Hitler, appena informato dell’armistizio, di voler fare tabula rasa dell’ex alleato “traditore”. Ha scritto Schreiber: “Senza esitare, un intero popolo fu dunque bollato di tradimento; e probabilmente l’odio profondo che in quel momento molti tedeschi provavano verso gli italiani, unito a sentimenti di vendetta, rese più facile ai militari eseguire quegli ordini criminosi” <263. Anche se le ragioni dei molti tragici eventi sul territorio italiano non possono essere addebitate solo al pregiudizio nei confronti degli italiani per motivi razziali o per motivi prevalentemente psicologici come reazione al tradimento degli italiani, quegli aspetti furono sicuramente una componente fondamentale alla base degli eccidi, delle stragi e delle rappresaglie.
Il fenomeno della lotta ai partigiani e alla popolazione civile diventò ancora più drammatico se si considera la partecipazione ai rastrellamenti e alle rappresaglie di formazioni dell’esercito della Rsi, di unità della Guardia nazionale repubblicana (Gnr) e di reparti speciali antipartigiani. Ciò spinse il rapporto tra fascisti e antifascisti sul terreno della guerra civile. Portava verso questo risultato, una volta costituita la Rsi, la necessità dei suoi dirigenti di salvaguardare la propria identità fascista e di non insospettire l’alleato tedesco, divenuto ancora più esigente e sprezzante nella sua nuova veste di alleato occupante. La lotta antipartigiana diventava così una priorità imprescindibile della Rsi, “che su essa misurava la sua possibilità di mediazione e di rappresentatività nei confronti della popolazione quanto di rilevanza nella valutazione dell’alleato tedesco” <264. Alla lotta alle bande perpetrata dai tedeschi che, come si è visto, contemplava azioni militari contro la popolazione consapevolmente calcolate come strumento di lotta, collaboravano le forze armate della Repubblica sociale italiana che si resero complici e direttamente responsabili, quando vi partecipavano, delle stragi o delle devastazioni. La collaborazione delle forze militari della Rsi risultava determinante per i tedeschi che nelle aree di montagna non conoscevano il territorio né la dislocazione delle bande partigiane. Per di più la brutalità esercitata nella “lotta alle bande” non era una prerogativa solo tedesca: le forze armate della Rsi non ne furono estranee. I capi della milizia fascista avevano impartito disposizioni altrettanto dure di quelle della Wehrmacht per la lotta antipartigiana. Le formazioni della Gnr dovevano “perseguitare il nemico finchè è morto (…) agire con la massima durezza tanto contro i banditi quanto contro coloro che gli aiutano” <265.
Le disposizioni draconiane impartite dai capi della milizia e consonanti alle direttive tedesche sulla “lotta alle bande” non furono in grado comunque di garantire l’ordine e la tranquillità nel territorio della Rsi. Il fallimento era imputabile principalmente alla Gnr che rappresentava l’ossatura dell’apparato interno della Rsi. Costituita mettendo assieme corpi diversi – la vecchia milizia con le formazioni dei carabinieri e della polizia coloniale (polizia dell’Africa italiana, PAI) – la Gnr fin dall’inizio del suo operato appariva ai gerarchi fascisti inaffidabile sia politicamente che militarmente. La soluzione di unificare forze quanto mai disparate, i carabinieri legati al giuramento al re possedevano un forte spirito di corpo che si contrapponeva agli ex miliziani fascisti che si consideravano l’avanguardia del Partito fascista, apparve infelice. Mentre la vecchia milizia continuava ad essere in condizioni desolanti, la polizia coloniale si era ridotta a meno di 2000 uomini e operava sostanzialmente a Roma agendo come servizio di sicurezza posto sotto il controllo tedesco. Un discorso a parte meritavano i carabinieri. All’inizio del 1944 essi costituivano il 40 % della Gnr e conservavano intatta l’organizzazione territoriale che costituiva il grosso dei distaccamenti della Gnr. I carabinieri apparivano da un punto di vista fascista del tutto inaffidabili perché la loro adesione alla Rsi era tiepida e non convinta. Essi si limitavano a compiere la normale attività amministrativa non esercitando controlli sull’attività dei partigiani che venivano considerati patrioti e che, sostenuti o temuti dalla popolazione, potevano operare indisturbati <266. La mancanza di elementi politicizzati o addirittura fascisti militanti nella Gnr non garantiva il controllo del territorio della Repubblica sociale. A ciò si aggiunge che una buona parte dei legionari era composta da renitenti – anch’essi considerati fascisti poco convinti – che subirono un “incarabinierimento”. La condizione di scarsa operatività della Gnr spinse il segretario del Partito fascista Pavolini a bollarla inaffidabile sia politicamente sia militarmente. La necessità per la Rsi di poter fare affidamento su una milizia fidata in un momento – l’estate del 1944 – in cui l’avanzata degli Alleati e l’incalzare del movimento partigiano facevano temere una fine rapida della guerra, portò alla formazione delle Brigate nere. Un corpo compatto d’elite creato con gli appartenenti al Partito fascista. Il 21 giugno 1944, Mussolini ordinò che dal 1° luglio gli iscritti al Partito fascista repubblicano di età compresa fra i 18 e i 60 anni costituissero il Corpo ausiliario delle camicie nere, che le federazioni del Partito si trasformassero in brigate il cui comando era da affidarsi ai capi politici locali, che tutta l’organizzazione del Pfr fosse militarizzata con la rinuncia ai compiti assistenziali e propagandistici. Per Mussolini militarizzare il partito e trasformarlo in una formazione armata rappresentava una garanzia perché i protagonisti erano, per la maggioranza, fascisti convinti e decisi a una guerra spietata alla Resistenza, inoltre non mancavano giovani attratti dalla maggiore volontà di lotta contro le forze antifasciste, in primis contro i partigiani, rispetto alle altre strutture della Rsi: “il brigatista nero rappresentava del resto il modello maschile per eccellenza: credente e combattente, doveva essere integerrimo, determinato e votato alla morte per Mussolini e la causa fascista” <267.
Le Brigate nere nacquero dunque con lo scopo dichiarato della lotta alla Resistenza, costituendo così il punto culminante dell’impegno fascista nella guerra civile, nella quale si segnalarono per la particolare crudeltà profusa nell’opera di repressione: “I compiti sono quelli del combattimento per l’ordine pubblico, per l’ordine rivoluzionario, per la lotta antiribellistica, per la liquidazione di eventuali nuclei di paracadutisti nemici (…) nelle azioni antiribelli le squadre non fanno prigionieri” <268. Pavolini pensava quindi alla necessità di porsi su un terreno che era di politici in armi contro politici in armi; che fosse l’idea politica l’arma in grado di cambiare le sorti della guerra a favore dei fascisti. Egli, che si impegnò in prima persona nella loro costituzione, sosteneva che “gli italiani non temono il combattimento (…) quelli che sono fedeli al Duce lo sono per davvero. Non amano, però, essere chiusi in caserma, inquadrati, irreggimentati, dover sottostare all’addestramento, portar veste e pesanti divise. Il movimento partigiano ha successo perché il combattente nelle file partigiane ha l’impressione di essere un uomo libero. Egli è fiero del suo operato, perché agisce indipendentemente e sviluppa l’azione secondo la sua personalità e individualità. Bisogna, quindi, creare un movimento antipartigiano sulle stesse basi e con le stesse caratteristiche.” <269
[NOTE]
252 Gerhard Schreiber, La vendetta tedesca 1943 – 1945: le rappresaglie naziste in Italia, Mondadori, Milano 2000, p. 91
253 Ivi, p. 93
254 Friedrich Andrae, La Wehrmacht in Italia. La guerra delle forze armate tedesche contro la popolazione civile 1943 – 1945, Editori Riuniti, Roma 1997, cit., p. 167
255 Klinkhammer, Stragi naziste in Italia, cit., p. 51
256 Ibidem
257 Ivi, p. 90
258 Schreiber, La vendetta tedesca, p. 98
259 Enzo Collotti, Tristano Matta, Rappresaglie, stragi, eccidi, in Enzo Collotti, Renato Sandri e Frediano Sessi (a cura di), Dizionario della Resistenza, vol. I, Storia e geografia della liberazione, Einaudi, Torino 2001, cit., p. 256
260 Ivi, p. 343
261 Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia, p. 354
262 Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia, cit., p. 29
263 Schreiber, La vendetta tedesca, p. 39
264 Bruno Maida, Prigionieri della memoria. Storia di due stragi della Liberazione, Franco Angeli, Milano 2002, cit., p. 61
265 Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia, cit., p. 335
266 Ivi, p. 306
267 Dianella Gagliani, Brigate nere, in Grazia e Luzzato (a cura di ) Dizionario del fascismo, cit., p. 200
268 Ivi, cit., p. 199
269 Ricciotti Lazzero, Le Brigate Nere. Il Partito armato della repubblica di Mussolini, Rizzoli, Milano 1983, cit., p. 23
Marco Pollano, La 17a Brigata Garibaldi “Felice Cima”. Storia di una formazione partigiana, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Anno Accademico 2006-2007
 Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)
Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)- Lo svolgimento del processo non piaceva all'amministratore della Divisione Garibaldi
- La salma di Ivanoe Amoretti è oggi custodita nel sacello 103 del Mausoleo delle Fosse Ardeatine insieme a quelle delle altre vittime dell’eccidio
- La recluta partigiana non conosceva ancora il comandante garibaldino
- Ben presto la fama della Feldgendarmerie come ‘squadrone della morte’ si era diffusa nella zona dell’albenganese
- Il Professore, traditore dei partigiani della Divisione Cascione
- L'indimenticabile medico dei partigiani, uomo di Isolabona
- Dopo circa 5 ore di attesa venne avvistato un camion pieno di soldati tedeschi e fascisti
- Il risultato fu che chi si presentò nelle 48 ore prestabilite venne inviato in Germania
- La Resistenza narrata dall'imperiese Osvaldo Contestabile
- Solo un piccolo gruppo di partigiani riesce ad agganciare il nemico che fugge perdendo materiale ed equipaggiamento
 Storia minuta
Storia minuta- I beni comuni nel costituzionalismo democratico: i lavori della Commissione Rodotà
- Segretario di Gramsci, generale sovietico, spia e, forse, disertore negli Stati Uniti
- Se in città c’è il pericolo delle bombe, in campagna c’è quello dei ribelli
- Il nuovo servizio del Viminale cercò di scavalcare il Sifar
- Il festival di Castelporziano assume il ruolo di consapevole apripista del filone polemico come cifra dell’effimero
- Verosimilmente, oltre agli esiti del referendum, contribuisce a spingere la Dc sulla difensiva anche il susseguirsi di rivelazioni emerse in seguito alle inchieste della magistratura
- Dall’estate del 1944 cominciano le operazioni di rastrellamento da parte delle forze tedesche tra il Pasubio e la Val Posina
- Le gerarchie del MSI entrarono spesso in polemica con Evola
- I rapporti tra i servizi segreti italiani e quelli statunitensi sono andati consolidandosi sin dall’immediato dopoguerra
- Parte di questa generazione sopperì alla lacuna degli atenei italiani in materia di sociologia frequentando facoltà affini come giurisprudenza, lettere o psicologia
 Piccola antologia
Piccola antologia- La prospettiva storica da cui muove Pusterla è pessimista, disincantata e delusa
- Circa il collezionismo d’azienda in Italia
- Nella Resistenza cronologicamente nasce la prima scrittura neorealista
- Una esplicita condanna del romanzo di Nanni Balestrini…
- De Giovanni non mi avrebbe forse mai fatto leggere le sue poesie
- Disegnare e dipingere, sempre in stato di trance
- Di certo la personalità di Kojève è tale da non lasciare indifferenti
- L’impressione era che, dovunque lo sceneggiatore vagasse nel labirinto hollywoodiano, saltava fuori il produttore a sbarrargli il cammino
- Il giornalismo muckraking è quindi stato una componente fondamentale della storia, se non addirittura della vita quotidiana, degli americani
- Il senso della bellezza e della storia sembrano scomparire nella serialità
 Frammenti di storia
Frammenti di storia- Scassellati trasportò nel comando i metodi sanguinari usati nella controguerriglia in Dalmazia
- La principale intuizione della Nuova Destra francese fu comprendere come la vicenda politica generale si spostava sul piano europeo
- La Banda Koch disponeva di un buon sistema di infiltrazione nel mondo partigiano
- Il Parco Naturale Alpi Marittime è la più vasta area protetta del Piemonte
- L’Ufficio mobilitati civili della Procura militare di Milano e le questioni di ordine pubblico
- Il primo governo di centro-sinistra vede infatti la luce solo nel dicembre del 1963
- L’estrema destra europea ha fornito manovalanza attiva a una specie di continuazione della Guerra Fredda
- Sia Nixon che Kissinger non erano entusiasti del ritorno alla formula di centrosinistra
- Il primo nucleo di resistenza armata nel vicentino si venne a creare in una zona piuttosto remota
- I finanziamenti di un ambasciatore americano
Adriano Maini
Adriano Maini
Da Bordighera (IM), Liguria
Servizi Verificati
-
Articoli recenti
- A Schio dal 27 aprile 1945 fu un continuo viavai di soldati tedeschi che razziavano tutto il possibile
- La Commissione di inchiesta sulla Loggia massonica P2 fu istituita con la legge 527/1981 durante la VIII legislatura
- Ragazzi di stadio
- De Gaulle divenne il modello di Sogno
- Verso le ore 10.30 transitava da Isola di Rovegno una colonna mista di partigiani
Archivi
- aprile 2024
- marzo 2024
- febbraio 2024
- gennaio 2024
- dicembre 2023
- novembre 2023
- ottobre 2023
- settembre 2023
- agosto 2023
- luglio 2023
- giugno 2023
- Maggio 2023
- aprile 2023
- marzo 2023
- febbraio 2023
- gennaio 2023
- dicembre 2022
- giugno 2021
- aprile 2020
- gennaio 2020
- dicembre 2019
- novembre 2019
- ottobre 2019
- settembre 2019
- agosto 2019
- luglio 2019
- giugno 2019
- Maggio 2019
- aprile 2019
- marzo 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- novembre 2018
- ottobre 2018
- settembre 2018
- agosto 2018
- luglio 2018
- giugno 2018
- Maggio 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- dicembre 2017
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- agosto 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- Maggio 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- agosto 2016
- luglio 2016
- giugno 2016
- Maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
- agosto 2015
- luglio 2015
- giugno 2015
- Maggio 2015
- aprile 2015
- marzo 2015
- febbraio 2015
- gennaio 2015
Meta